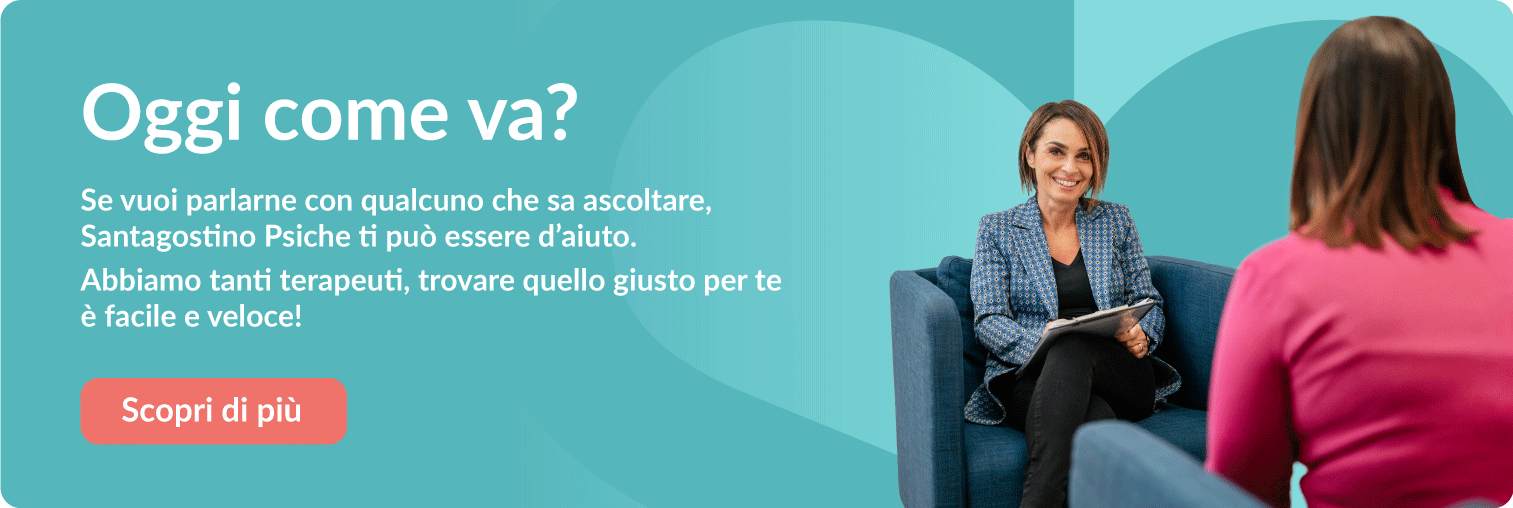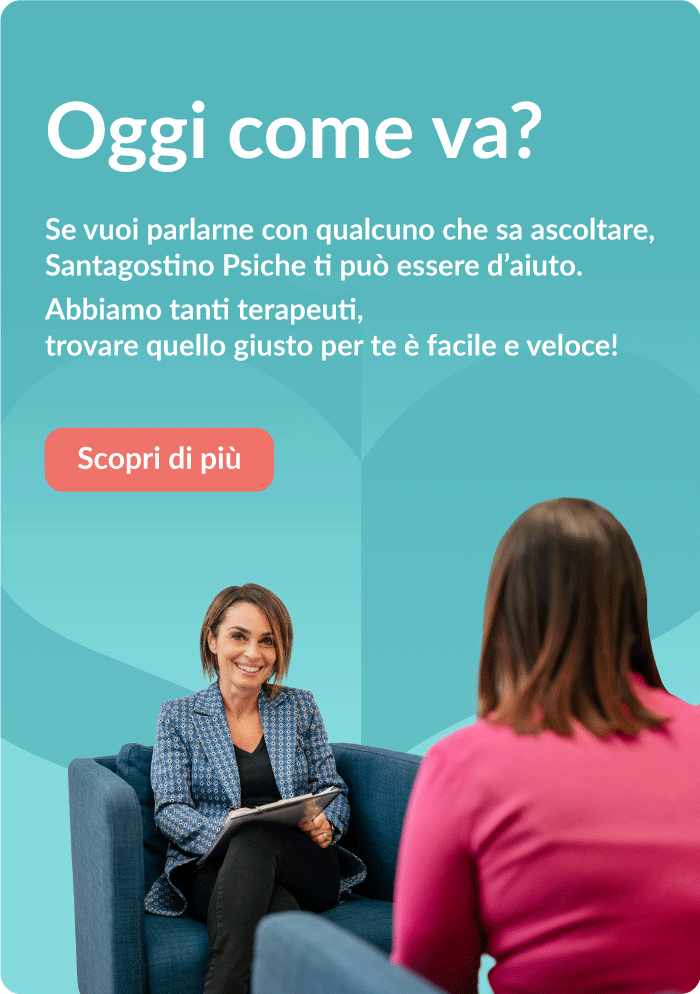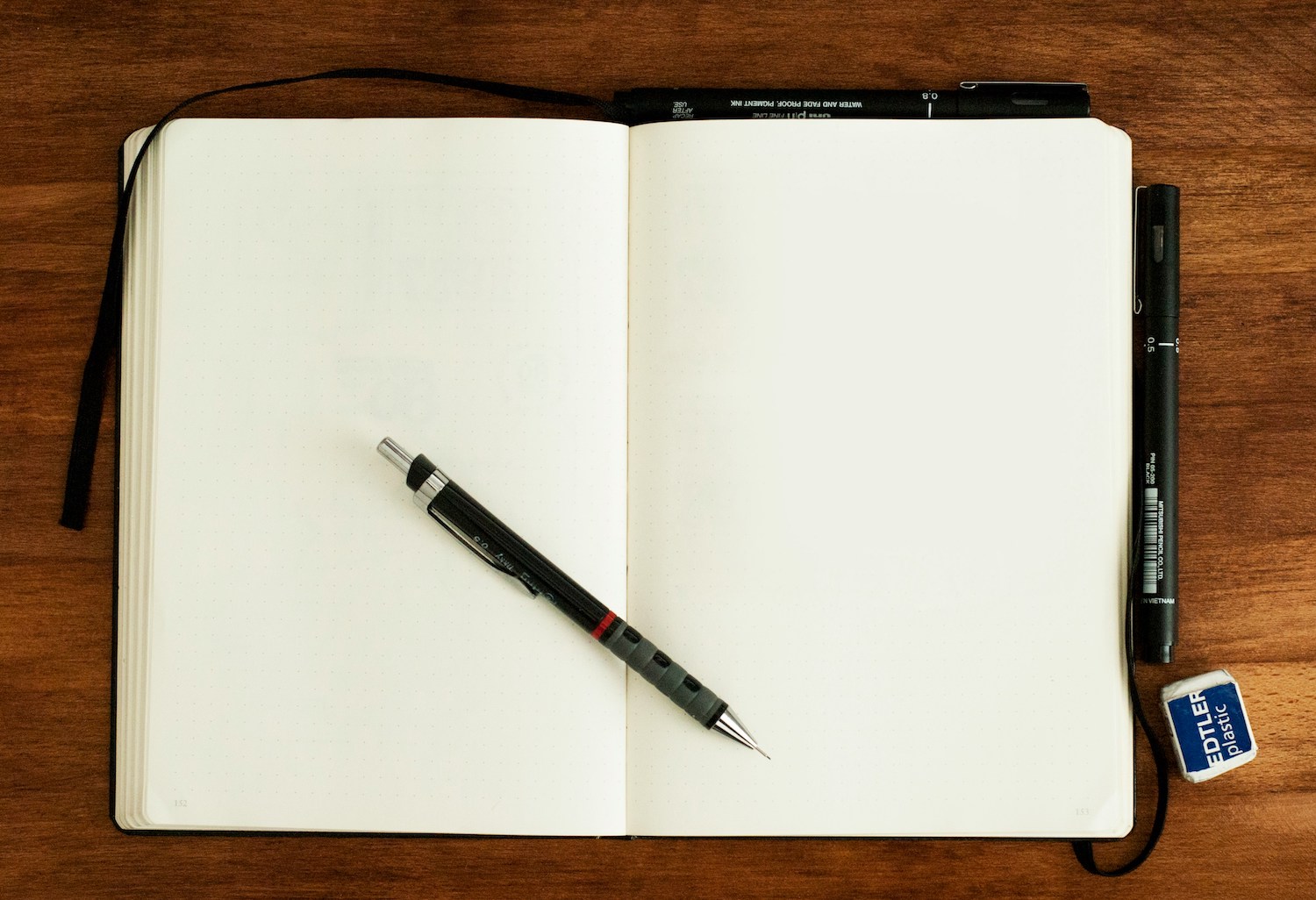Il Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività (ADHD) rientra nella categoria dei Disturbi del Neurosviluppo che esordiscono nell’infanzia e causano una compromissione nel funzionamento personale, sociale, scolastico o lavorativo.
In questo articolo cercheremo di chiarire, con l’aiuto della dottoressa Francesca Grotta, psicologa e psicoterapeuta del Santagostino specializzata in Neuropsicologia dello Sviluppo, quali sono le possibili cause alla base del deficit dell’attenzione, quali le principali manifestazioni e come intervenire per diagnosticare e trattare questo disturbo.
Che cosa è l’ADHD?
ADHD è acronimo di Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività. È una condizione neurobiologica che colpisce principalmente i bambini, ma può persistere anche in età adulta. Si caratterizza per la presenza di sintomi di inattenzione, iperattività e impulsività, che possono influenzare significativamente il funzionamento quotidiano e il rendimento scolastico.
La sintomatologia dell’ADHD può variare da individuo a individuo, ma comunemente include difficoltà nell’attenzione sostenuta, nella concentrazione, nel controllo degli impulsi e nell’organizzazione delle attività. I bambini con ADHD possono apparire distratti, impulsivi, avere difficoltà a seguire istruzioni, dimenticare spesso le cose e mostrare una costante irrequietezza.
Secondo i dati riportati nel secondo Convegno Regionale AIFA APS Liguria, del marzo 2023, questo disturbo ha una prevalenza del 4% sulla popolazione generale italiana.
Deficit dell’attenzione: le cause possibili
Le cause del deficit dell’attenzione, o ADHD, possono essere di varia natura e raggruppabili in tre categorie:
- genetiche
- neurobiologiche
- ambientali
Le cause genetiche
Sono molti gli studi familiari che mostrano un’alta prevalenza di ADHD nei parenti dei pazienti affetti da questo disturbo. Inoltre, è stata dimostrata l’esistenza di un’associazione tra deficit dell’attenzione e alcuni geni come quello responsabile della produzione di dopamina, un neurotrasmettitore.
Cos’è la dopamina? Una sostanza che media/passa le informazioni tra neuroni e, quindi, è alla base di molti processi cognitivi, come ad esempio attenzione e memoria. Per curare il disturbo dell’attenzione quindi, proprio per queste evidenze scientifiche, nonostante non siano ancora consistenti, la maggior parte dei farmaci utilizzati aumenta l’efficacia dell’attività della dopamina nella comunicazione tra neuroni, aiutando così il paziente a prestare maggiore attenzione.
Bisogna ricordare come la terapia farmacologica non sia sempre necessaria e soprattutto come sia importante affiancare un lavoro specifico con lo psicologo.
Le ragioni neurobiologiche
Con l’ADHD possiamo parlare di predisposizione neurobiologica (ci possono essere soggetti più a rischio di altri, ma non è detto che sviluppino il disturbo) come avviene per la maggior parte dei disturbi del neurosviluppo. Questa predisposizione si intreccia con l’effetto dell’ambiente: il rischio di sviluppare il disturbo aumenta se alla predisposizione si aggiungono fattori negativi ambientali, mentre diminuisce in presenza di fattori protettivi ambientali.
Quali sono i fattori ambientali negativi?
L’esposizione intrauterina ad alcool o nicotina, la nascita pretermine del bambino e il basso peso alla nascita, infine disturbi cerebrali del bambino (encefaliti, traumi). Tali fattori non causano in maniera diretta questo disturbo ma possono favorire la comparsa di alterazioni nei geni, che portano poi all’insorgenza del disturbo dell’attenzione.
I fattori ambientali
I fattori ambientali “modulano” l’effetto dei fattori biologici. Quelli che portano a una maggiore espressione della sintomatologia sono:
- instabilità familiare
- conflittualità genitoriale
- disturbi psicologici dei genitori
- stress familiare per cause contingenti (lutti, problemi economici, trasferimenti, traumi e tutti i cambiamenti non desiderati e fonte di preoccupazione e stress nei genitori e/o nel bambino)
- scarsa competenza dei genitori
- rapporto negativo bambino-genitori
- rapporto negativo bambino-insegnanti.
Quali sono i sintomi dell’ADHD?
Il deficit dell’attenzione è caratterizzato da un pattern persistente di disattenzione e/o iperattività-impulsività che interferisce con il funzionamento o lo sviluppo del bambino. Inoltre, l’ADHD si sovrappone frequentemente a disturbi quali il Disturbo Oppositivo-Provocatorio e il Disturbo della Condotta. Spesso, inoltre, permane in età adulta. In questa fase i sintomi più frequenti sono:
- impulsività
- disorganizzazione e difficoltà a definire priorità
- deficit nella gestione del tempo
- difficoltà a focalizzarsi su un compito
- difficoltà a portare a termine più compiti contemporaneamente
- irrequietezza e agitazione motoria
- difficoltà di programmazione di attività
- bassa tolleranza alla frustrazione
- frequenti sbalzi d’umore
- temperamento irascibile
- difficoltà a fronteggiare lo stress.
La presenza di ADHD è stimata in circa il 5% dei bambini ed il 2,5% degli adulti.
L’ADHD è un disturbo neurobiologico, dovuto alla disfunzione di alcune aree e di alcuni circuiti del cervello e allo squilibrio di alcuni neurotrasmettitori (come noradrenalina e dopamina), responsabili del controllo di attività cerebrali come l’attenzione e il movimento.
Eventuali test per il deficit di attenzione
Nonostante non esistano test diagnostici specifici per il deficit dell’attenzione, è di fondamentale importanza che il bambino venga sottoposto ad una valutazione testale al fine di delineare il profilo di funzionamento cognitivo e comportamentale.
La letteratura scientifica, ad oggi, offre diversi strumenti (test neuropsicologici, i questionari per genitori ed insegnanti e le scale di valutazione) volti a misurare la severità del disturbo e seguirne nel tempo l’andamento. Inoltre, sono spesso cruciali per individuare eventuali patologie associate (disturbi d’ansia o dell’umore, disturbi specifici dell’apprendimento) e per studiare i meccanismi neuro-biologici che ne sono alla base.
L’iperattività motoria, il disturbo dell’attenzione ed il comportamento impulsivo e aggressivo possono essere sintomi di numerosi disturbi psicopatologici. Occorre quindi sempre verificare se tali patologie “simulino” l’ADHD o se, invece, siano associate all’ADHD (comorbidità).
Come si fa a diagnosticare I’ADHD?
In linea generale, quando si sospetta che un bambino possa essere considerato come affetto da ADHD occorre:
- raccogliere informazioni da fonti multiple (genitori insegnanti, educatori) utilizzando interviste semi-strutturate e/o questionari standardizzati sui diversi aspetti del comportamento e del funzionamento sociale del bambino.
- effettuare un colloquio (esame psichico) col bambino per verificare la presenza di altri disturbi associati. Anche in questo caso, le scale standardizzate di autovalutazione del bambino, come ansia o depressione ad esempio, possono essere utili.
- valutare le capacità cognitive e l’apprendimento scolastico; valutare in maniera oggettiva le capacità attentive, di pianificazione delle attività e di autocontrollo. Talvolta può essere utile valutare la possibile presenza di disturbi del linguaggio.
- effettuare l’esame medico e neurologico, valutando la presenza di possibili patologie associate e gli effetti di eventuali altre terapie in atto.
Quanto dura l’ADHD?
L’ADHD è una condizione cronica, il che significa che tende a persistere nel tempo. Mentre alcuni bambini possono sperimentare una riduzione dei sintomi con l’avanzare dell’età, molti individui continuano a manifestare tratti caratteristici anche in età adulta. L’espressione dei sintomi può variare e le strategie di adattamento e di gestione dell’ADHD possono migliorare con l’età e l’esperienza.
L’ADHD, occorre specificare, non è semplicemente una fase di sviluppo o un tratto caratteriale passeggero. È invece un vero e proprio disturbo che richiede una valutazione clinica accurata per una diagnosi corretta. E sebbene l’ADHD sia spesso diagnosticato in età pediatrica, e si protragga anche durante l’adolescenza, è possibile che sia riconosciuto solo in età adulta, quando i sintomi possono persistere o manifestarsi in modo diverso rispetto all’infanzia.
Come vive un ADHD?
La vita di una persona con ADHD può essere influenzata da diversi fattori. Le difficoltà nell’attenzione e nell’organizzazione possono rendere complesse le attività quotidiane, come la gestione dei compiti, la pianificazione delle attività e il mantenimento di routine regolari. Ciò può portare a sfide nell’ambito scolastico, lavorativo e nelle relazioni interpersonali.
Le persone con ADHD possono sperimentare frustrazione, senso di colpa e bassa autostima a causa delle difficoltà incontrate. Possono sentirsi inadeguate o percepire di non riuscire a raggiungere il loro pieno potenziale. Eppure, non va dimenticato che le persone con ADHD possono avere anche punti di forza unici, come creatività, pensiero laterale e capacità di pensiero rapido.
Cosa non fare con bambino ADHD?
Quando si interagisce con un bambino con ADHD, è importante evitare alcune pratiche che potrebbero essere inefficaci, se non dannose, nel gestire i sintomi del disturbo. Innanzitutto, è vitale non etichettare il bambino come cattivo o pigrone, dal momento che l’ADHD è una condizione neurobiologica che richiede un sostegno adeguato, non uno stigma.
Si sconsiglia poi ricorrere a punizioni severe o umilianti come strategia disciplinare. Queste pratiche non solo possono danneggiare l’autostima del bambino, ma non sono efficaci nel modificare il comportamento associato all’ADHD. È preferibile invece adottare un approccio positivo, ricompensando il comportamento appropriato e utilizzando strategie di rinforzo positivo.
Non bisogna quindi sottovalutare il valore e l’efficacia dell’intervento professionale. La consulenza di uno psicologo specializzato nel trattamento dell’ADHD può fornire una guida preziosa per genitori e insegnanti nella gestione dei sintomi e nell’implementazione di strategie efficaci per l’apprendimento e lo sviluppo.
L’ADHD è curabile?
In senso stretto, non è possibile parlare di una cura definitiva per l’ADHD, ma il disturbo può essere trattato efficacemente attraverso un approccio multimodale che coinvolge interventi psicologici, educativi e farmacologici, se necessario. Gli interventi psicologici includono, come sarà approfondito, terapia comportamentale, interventi educativi mirati, supporto familiare e strategie di gestione dell’ambiente.
La terapia farmacologica può essere prescritta in alcuni casi per ridurre i sintomi dell’ADHD. I farmaci stimolanti, come il metilfenidato, sono spesso utilizzati e si sono dimostrati efficaci nel migliorare l’attenzione e la concentrazione nei pazienti con ADHD.
Il trattamento dell’ADHD è comunque individuale, e varia in base alle esigenze e alle caratteristiche del paziente. L’obiettivo principale del trattamento è quello di ridurre i sintomi, migliorare la funzionalità e promuovere l’adattamento sociale e scolastico.
Come si cura il deficit di attenzione?
Il trattamento del deficit dell’attenzione è di tipo multimodale, ovvero possono essere necessari interventi di tipo farmacologico e psicoterapeutico. L’intervento farmacologico non è sempre necessario mentre quello psicoterapeutico sì.
I soggetti coinvolti nel percorso psicoterapeutico sono sia il bambino con diagnosi di ADHD, sia i familiari che gli insegnanti.
Child training (sviluppare attenzione e autoregolazione)
I bambini con il disturbo dell’attenzione possono beneficiare di una terapia di tipo cognitivo-comportamentale indirizzata sinergicamente verso tutti gli aspetti coinvolti nel disturbo:
- al bambino viene insegnato a pianificare il proprio comportamento nei diversi ambiti di vita e nella risoluzione dei problemi
- lo si aiuta ad acquisire la capacità di autoregolazione dell’impulsività e della disattenzione
- gli si insegna a imparare dai propri errori per autocorreggersi, ma anche a premiarsi quando raggiunge risultati positivi
- si lavora sulle sue abilità sociali, concentrandosi sull’importanza del rispetto delle regole, lo sviluppo di interazioni efficaci e la capacità di comprendere lo stato emotivo altrui.
Terapia farmacologica
Gli psicostimolanti sono considerati i farmaci più efficaci per adolescenti, bambini e adulti con ADHD. I principali effetti positivi riguardano:
- mantenimento dei livelli di attenzione
- controllo dell’impulsività
- gestione dell’iperattività.
L’utilizzo del farmaco per il trattamento dell’ADHD è gestito e monitorato dai Centri di Riferimento Regionali iscritti al Registro Italiano per l’ADHD.
È bene sottolineare che un intervento di tipo farmacologico dovrebbe sempre essere affiancato ad un intervento di tipo psicologico-comportamentale: parent training, child training e teacher training. Inoltre, nonostante la terapia farmacologica venga seguita nei centri regionali di riferimento, la terapia psicologica può essere attivata in qualsiasi centro privato.
Parent training (strategie educative e stili genitoriali)
Per aumentare la consapevolezza e conoscenza del disturbo da deficit dell’attenzione, il coinvolgimento diretto dei genitori è necessario. In questo modo, sarà possibile correggere gli eventuali comportamenti disfunzionali adottati con i propri figli.
Il punto focale del parent training è quello di far sviluppare ai genitori maggiori capacità riflessive in modo da far acquisire loro strategie di educazione che aiutino il bambino ad autogestirsi.
Inoltre, questi tipi di intervento possono promuovere un miglior clima emotivo in famiglia, migliorando la comunicazione con il bambino e definendo le regole da seguire.
Teacher training (strategie per la gestione del comportamento in classe)
Il coinvolgimento degli insegnanti, così come quello dei genitori, ha lo scopo di fornire, inizialmente, le informazioni necessarie a raggiungere una piena conoscenza del disturbo dell’attenzione
Diviene centrale in tale ottica fornire agli insegnanti informazioni su una strutturazione dell’ambiente scolastico che tenga in considerazione bisogni e caratteristiche del bambino iperattivo, per potenziare le sue capacità attentive e gli apprendimenti.
Gli insegnanti devono, inoltre, acquisire strategie utili alla gestione e modifica dei comportamenti disfunzionali e volte a migliorare il rapporto del bambino con i suoi coetanei.
(9 Maggio 2022)