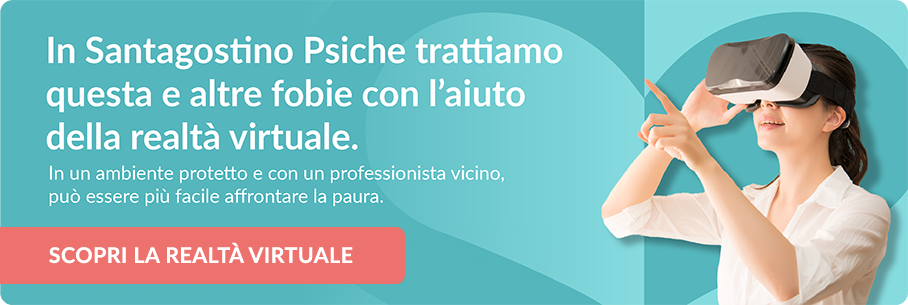Nella persona che soffre di filofobia, amore e fobia sono due realtà apparentemente inestricabili.
L’aver paura di amare può rendere complesso, se non impossibile, lasciarsi andare e perdere il controllo, in modo sano, all’interno del rapporto di coppia.
Il primo passo allora è capire come questa chiusura, che può anche determinare veri e propri sintomi tipici dell’ansia, quali tachicardia e fiato corto, non porti da nessuna parte e rischi di precludere una felice vita affettiva alla persona che ne soffre.
Superare questa fobia è però possibile, anche grazie all’aiuto di un terapeuta. Ce ne parla la dottoressa Ilaria Bellavia, psicologa e psicoterapeuta psicodinamica del Santagostino.
Come si definisce la filofobia?
La filofobia si definisce, ad oggi, come l’incapacità per il soggetto di provare sentimenti e stati d’animo inerenti l’amare l’altro da sé. Il termine filofobia deriva dal greco filia, che vuole dire amore e fobia, che vuol dire paura.
In sintesi, possiamo dire che questa condizione ha a che fare con la paura di innamorarsi. Può anche riguardare la paura di entrare in una relazione o la paura di non essere in grado di mantenere una relazione affettiva importante. Molte persone, ad esempio, sperimentano talvolta piccole paure di fronte alla possibilità di innamorarsi, con un potenziale partner ad un certo punto della loro vita.
In casi estremi, la filofobia può far sentire le persone isolate, sole, e non amate.
Questa fobia è presente nel DSM?
La filofobia non è una condizione che possiamo rintracciare all’interno del DSM. Un clinico attento e scrupoloso può comunque aiutare la persona ad uscire da questo stato di sofferenza e di immobilità.
Come capire se si soffre di filofobia?
I sintomi variano di persona in persona. Tuttavia, molte persone con esperienza di filofobia avvertono una mancanza di relazioni affettive intime, si sentono sempre ansiose nelle relazioni e nel coinvolgimento emotivo.
In situazioni relazionali si potrebbero verificare:
- battito cardiaco accelerato
- fiato corto e/o dispnea da ansia
- veri e propri attacchi di panico
- ansia.
Condizioni, queste ultime, che possono includere dolori al petto.
Le persone che hanno casi persistenti o più estremi legati alla filofobia possono avere un aumentato rischio di:
- depressione
- abuso di sostanze e dipendenze patologiche
- ideazione suicidaria.
I sintomi della filofobia tendono ad essere automatici, lasciando al malato la sensazione di avere poco o nessun controllo sul modo in cui si sente.
Ciò si traduce spesso nell’uso di comportamenti di evitamento o di sicurezza e nel tentativo di prevenire l’esposizione a quelli che vengono considerati gli eventi scatenanti. Sfortunatamente, i comportamenti di sicurezza tendono a produrre un effetto paradossale e finiscono per rafforzare la fobia e il disagio associato, piuttosto che migliorare le cose.
Da cosa può essere causata la filofobia?
La filofobia può essere il risultato di precedenti esperienze traumatiche che possono essere direttamente o indirettamente collegate all’oggetto o ad una paura situazionale. Non è però sempre così perché le risposte fobiche possono anche essere ereditate come comportamenti appresi dal contesto sociale in cui la persona è cresciuta.
Nel corso del tempo, la filofobia potrebbe essersi normalizzata o accettata come parte della vita di una persona. In tal caso, chi ne è affetto potrebbe non cercare aiuto per molti anni avendo imparato a conviverci.
In altri casi, tuttavia, la filofobia può peggiorare molto e arrivare a intralciare la vita normale. Ciò è particolarmente vero se i comportamenti di sicurezza e di evitamento sono cresciuti in frequenza e sofisticatezza.
Come si comporta un filofobico?
Il filofobico tende a distorcere la realtà e la inventa in un certo modo sulla base dei propri pensieri. Pensieri che a loro volta sono il risultato delle proprie esperienze passate. E se le esperienze non sono state particolarmente buone, questo trasformerà il presente in una sorta di clone di quel passato, facendolo accadere di nuovo in una forma recidivante.
Il problema non è il presente che stiamo vivendo con un o una partner, ma il futuro che pensiamo di avere se andiamo avanti. In questo senso, la persona che soffre di filofobia pensa troppo, la sua realtà si perde all’interno di una nebbia mentale senza che nulla sia fatto per vivere il rapporto di coppia, per apprezzarlo, studiarlo o goderselo.
Spesso le persone affette da filofobia sprecano gran parte delle loro energie mentali nella ruminazione, creando una empasse caratterizzata dalla ripetizione ossessiva di pensieri intrusivi. È anche frequente che il fallimento di una relazione passata (ad esempio un divorzio o la fine di una relazione particolarmente importante) si riveli il fattore scatenante per la filofobia.
La filofobia può anche essere il risultato di un’educazione influenzata dalla presenza di alti e bassi nella relazione con i propri genitori.
Chi soffre di filofobia?
Il comportamento di una persona filofobica presenta tipicamente alcuni tra i seguenti comportamenti:
- evitamento emotivo di situazioni che potrebbero portare all’instaurarsi di una relazione affettiva, romantica. La persona si ritrova a evitare appuntamenti, a non esprimere i propri sentimenti o evitare situazioni in cui potrebbe svilupparsi una relazione più intima
- paura dell’abbandono e una forte paura di essere feriti emotivamente in una relazione. Questa paura può portare a una certa diffidenza o alla messa in atto di comportamenti di distanza emotiva come modalità per proteggersi, in modo anticipatorio, dal potenziale dolore
- ambivalenza emotiva verso l’amore e le relazioni. Le persone filofobiche possono sentirsi attratte emotivamente da qualcuno, ma allo stesso tempo provare paura o ansia riguardo all’approfondimento del legame. Una simile ambivalenza può generare un senso di conflitto interno
- difficoltà nel fidarsi degli altri, specialmente quando si tratta di questioni di ordine emotivo. Questa diffidenza può rendere difficile lasciarsi andare e aprirsi completamente in una relazione
- isolamento emotivo. A causa della paura legata all’amore e all’impegno, le persone filofobiche possono tendere a isolarsi emotivamente e a mantenere una certa distanza dalle persone che potrebbero entrare nella loro vita in modo più intimo.
Come relazionarsi con un filofobico?
Come psicologa clinica mi sentirei di dire che con un filofobico possa essere necessaria una forma speciale di empatia, ovvero quella psicoanalitica di cui Stefano Bolognini – nel suo testo L’empatia psicoanalitica, pubblicato nel 2002 da Bollati-Boringhieri – parla in modo esteso.
Allo stesso tempo è bene che il filofobico non senta lo psicologo clinico, o qualsiasi altra figura professionale di riferimento troppo invadente, inaffidabile. È bene dire esplicitamente al filofobico che ci siamo per qualsiasi cosa. A quel punto sarà la persona filofobica a richiedere la nostra presenza empatica e supportiva. Non possiamo sostituirci alla persona che soffre di filofobia, ma possiamo funzionare da sé ausiliario per quella persona.
Come afferma il medico e psicanalista Heinz Kohut, il senso del sé è fondamentale in quei pazienti affetti da problematiche narcisistiche, in cui vi sia un profondo difetto a carico dell’empatia.
Quando un filofobico si innamora?
Quando una persona filofobica si innamora, attraversa un insieme di reazioni emotive che possono essere particolarmente in contrasto tra loro, proprio per via del timore dell’amore e dell’impegno.
Se infatti, da un lato, viene riconosciuto il desiderio di avere una relazione e di connettersi emotivamente con la persona per la quale si prova amore, la paura dell’abbandono o del dolore emotivo può impedire un’apertura completa.
Un filofobico potrebbe manifestare comportamenti evitanti, come indicato, e non solo porre una distanza emotiva, ma anche sabotare la relazione, o ritirarsi del tutto. Un ritiro che può accadere evitando di dirlo alla persona coinvolta, attuando un comportamento tipico del ghosting. Altre volte, è possibile che sia mantenuta una distanza di sicurezza emotiva, per così dire, per schivare eventuali ferite sentimentali.
Come amano gli anaffettivi?
Gli anaffettivi sono il più delle volte alla ricerca di continue conferme rispetto a sé stessi. Sono poco empatici e vivono le relazioni con gli altri come conferma del proprio essere adeguati e capaci.
Allo stesso tempo temono il giudizio altrui a causa di una loro fragilità. Tendono a sottostimarsi e, talvolta, finiscono col mettere in atto degli autosabotaggi in modo da non esporsi troppo sul piano affettivo.
Le persone filofobiche cercano invece attivamente la vicinanza affettiva, anche se poi hanno difficoltà a gestirla. Questo aspetto li distingue dagli individui anaffettivi, che non desiderano relazioni non perché temono l’affetto, ma perché non sono in grado di provare sentimenti.
Questa distinzione è essenziale, poiché coloro che temono di amare sentono comunque il desiderio di affetto anche se ne hanno paura. I sintomi si manifestano quando la relazione si stabilizza e si presenta la possibilità di lasciarsi andare ai veri sentimenti.
In che modo intervenire con una terapia?
Si tenga conto, per prima cosa, che i diversi test presenti online non permettono affatto una diagnosi.
La terapia psicodinamica, ad esempio, lavora su aspetti legati all’ansia, all’aspetto fobico del disturbo, ma anche su aspetti inerenti l’autostima, la capacità di sentire l’altro e di prendere contatto con sé stessi senza paure o condizionamenti. Importante è che il terapeuta crei una relazione di fiducia, non giudicante all’interno della quale poter lavorare. In modo efficace sul disturbo e sull’equilibrio psicologico della persona.
Contestualmente ad una psicoterapia, la persona filofobica può agire in diversi modi. Può iniziare a praticare mindfulness e utilizzare tecniche di rilassamento, così da iniziare a gestire episodi ansiosi. In questo modo sarebbe meno complesso iniziare a vivere nel presente anziché proiettarsi nel futuro con paure immaginarie, con una possibile riduzione della tensione emotiva.
L’esposizione graduale alle situazioni che scatenano la paura può essere parte integrante del trattamento. Avvicinarsi per gradi a relazioni di tipo affettivo e romantico, così da sviluppare un sempre più radicato senso di sicurezza e di fiducia, può aiutare a disinnescare i meccanismi di autodifesa associati alla filofobia.
(11 Dicembre 2023)