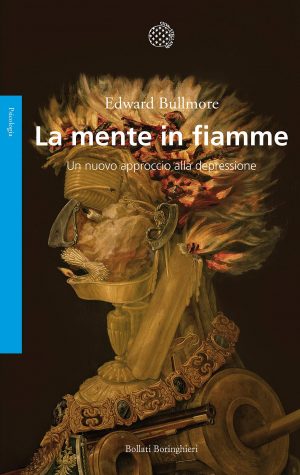La depressione potrebbe avere origine da un’infiammazione che si estende dal corpo al cervello. L’ipotesi del neuroscienziato inglese Edward Bullmore, benché accreditata da diversi studi in corso, incontra resistenze nell’ambiente medico. Questo, infatti, tende ancora a tenere rigidamente divise le scienze del corpo da quelle della mente.
È in atto una rivoluzione nel modo di pensare alla depressione. Se ne fa portavoce Edward Bullmore, professore di psichiatria all’Università di Cambridge e autore di La mente in fiamme (Bollati Boringhieri). Ospite del recente Festival della mente di Sarzana, Bullmore ha esposto la teoria a cui lavora da 30 anni: la depressione sarebbe, almeno in un terzo dei casi, il risultato di un processo infiammatorio che coinvolge l’organismo e che si estende al cervello. Il che aprirebbe la strada a filoni di ricerca del tutto nuovi: per esempio la ricerca di biomarcatori nel sangue utili a diagnosticare la depressione, e la sperimentazione di farmaci del tutto diversi dagli antidepressivi attuali. Ma proporre questo punto di vista non è per niente semplice. Vediamo perché.
Dalla bile nera alla serotonina
La riflessione di Bullmore è partita quando, fresco di specializzazione, si è trovato di fronte un paziente che lamentava pensieri pessimistici, senso di colpa, mancanza di piacere nel fare le cose, calo dell’appetito, disturbi del sonno. “Lei è depresso” aveva diagnosticato. Il paziente non si era scomposto, si era anzi mostrato infastidito per l’orgoglio con cui quel giovane medico constatava un’ovvietà. Cercando di riscattarsi, Bullmore aveva rassicurato l’uomo informandolo dell’esistenza di vari farmaci antidepressivi che lo avrebbero aiutato a stare meglio “correggendo lo squilibrio della serotonina”. Di nuovo il paziente aveva storto il naso: come faceva a sapere – gli aveva chiesto – che i suoi livelli di serotonina non andavano bene? A quel punto Bullmore si era bloccato. La verità era che non lo sapeva, e non avrebbe mai potuto saperlo perché non esistevano esami che misuravano i livelli di serotonina nel cervello. Si era sentito una specie di ciarlatano, che recita una formula imparata a memoria ma senza basi concrete. Non esistono infatti biomarcatori della depressione. Per alcune patologie è più semplice: per esempio, la glicemia che orienta verso una diagnosi di diabete o al calo di emoglobina che conferma un quadro di anemia. Anche per questa ragione, non è possibile prevedere se un paziente depresso risponderà alla terapia o no, e a quale dosaggio del farmaco: si procede per tentativi ed errori, sapendo che oltre un terzo dei pazienti non avrà alcun beneficio dalla terapia. Insomma: secondo Bullmore non abbiamo fatto tanti passi avanti da quando Ippocrate, 2500 anni fa, sosteneva che la “melancolia” dipendeva da un eccesso di “bile nera”.
La ricerca è bloccata
E in effetti la ricerca sui farmaci antidepressivi è giunta a un vicolo cieco. Nonostante l’OMS preveda che nel 2030 la depressione sarà la prima causa di invalidità nel mondo, da molto tempo le case farmaceutiche hanno smesso di mettere in commercio nuove molecole per combatterla. “Siamo ben lontani dal trionfalismo degli anni Novanta, quando un farmaco come il Prozac (la fluoxetina) si guadagnava le prime pagine dei giornali” ha osservato Bullmore. Oggi l’industria ha interrotto ogni trial sugli antidepressivi (costosissimi e con risultati pressoché nulli), nell’attesa che qualcuno proponga un cambiamento radicale alla direzione della ricerca.
Come trovare una strada nuova? Bullmore si è così avvicinato ai teorici della neuroimmunologia e si è concentrato sull’infiammazione. L’infiammazione è quel processo per cui, quando ci procuriamo una ferita, la zona della lesione si gonfia e duole: questo fenomeno è in realtà la punta di un iceberg di una serie di cambiamenti che coinvolge il sistema immunitario, e che inizia con l’aumento di macrofagi e citochine nel sangue. I vasi sanguigni si dilatano, permettendo un maggior afflusso di sangue nell’area danneggiata e rilasciando fluidi che si accumulano nella zona della lesione, da cui il calore e il gonfiore. Questo processo complesso, che serve a tenerci in vita di fronte a ogni tipo di attacco, è alla base di molte condizioni patologiche.
L’apartheid medico
Durante il suo tirocinio come medico, ricorda Bullmore, una volta si era imbattuto nella signora P, affetta da artrite reumatoide, una malattia infiammatoria dovuta a una reazione autoimmune contro le articolazioni. Oltre alle articolazioni doloranti e gonfie, la signora lamentava anche pensieri negativi e pessimistici, sensi di colpa, disturbi del sonno e altri sintomi che corrispondevano a un quadro di depressione. Bullmore aveva informato il suo primario, ma questi non vi aveva trovato nulla di strano: “Ci sfido che è depressa con la malattia che ha”. Come dire: è ovvio che una malattia fisica possa causare una malattia psichica (se si è malati ci si deprime per l’idea di avere una malattia), ma le due cose non sono biologicamente legate. La sua risposta rispecchiava la mentalità del tempo (stiamo parlando di una trentina di anni fa): era considerato impossibile che una malattia fisica potesse estendersi al cervello a causa della barriera ematoencefalica, una sorta di muro di Berlino che si riteneva impedisse il contatto fra cervello e resto del corpo. Un preconcetto che era figlio, in realtà, di un paradigma filosofico molto radicato nel mondo medico: l’idea, esposta da Cartesio nel ’600, che mente e corpo (la “res cogitans” e la “res extensa”) siano due cose ben distinte.
Oggi invece ci sono le prove che mente e corpo parlano attraverso il sistema immunitario, poiché le citochine riescono a bypassare il “muro di Berlino” cerebrale. Tanto è vero che almeno il 40 per cento delle persone con artrite reumatoide (e, più in generale, con malattie autoimmuni) sviluppa sintomi depressivi. In altre parole, secondo Bullmore, la signora P non era depressa perché sapeva di avere un’infiammazione ma perché era infiammata. In una malattia autoimmune, infatti, l’infiammazione non coinvolge solo una parte del corpo (come quando ci si procura un taglio), ma tutto il corpo. Cervello compreso.
Studi indiziari
È stato dimostrato che i depressi hanno nel sangue livelli più elevati di proteine infiammatorie (per esempio la proteina C reattiva, o PCR, un indice infiammatorio molto utilizzato negli esami del sangue di routine). In generale, tutte le condizioni caratterizzate da un’infiammazione cronica, dalla malattia coronarica al diabete, dall’obesità alle malattie autoimmuni, dalla parodontite al colon irritabile, sono spesso associate alla depressione. E alcuni studi orientano verso un nesso causale di tipo biologico, dimostrando che l’aumento degli indici infiammatori precede lo sviluppo della depressione. Per esempio lo studio coordinato dallo psichiatra inglese Golam Khanaker, che ha coinvolto 15.000 bambini di 9-10 anni, ha dimostrato che quelli con alti livelli di proteine infiammatorie avevano, a distanza di 10 anni, maggiori possibilità di sviluppare un quadro depressivo.
Oltre a varie patologie croniche, a favorire un quadro infiammatorio è anche lo stress sociale: i lutti, la perdita del lavoro, il divorzio, il caregiving (la necessità di accudire una persona malata o anziana) sono tutte condizioni che alzano gli indici infiammatori. Il sistema immunitario reagisce a una situazione di stress come se si trattasse di una ferita.
Ma perché si sarebbe evoluto un processo che, in corrispondenza di malattie infiammatorie dell’organismo o di situazioni stressanti, provoca sintomi depressivi? Al momento si possono fare ipotesi. Forse per i nostri antenati uno stato depressivo, che portava a isolarsi dal gruppo sociale innescando una sorta di quarantena volontaria, permetteva di evitare la diffusione di malattie contagiose (nel caso la causa dell’infiammazione fosse una malattia infettiva). Oppure, in caso di infiammazioni di altra natura, la depressione poteva portare ad allontanarsi dal fattore stressante e a riorganizzare la vita diversamente, a innescare cioè un cambiamento necessario per la sopravvivenza.
-Leggi anche: tDCS, un tipo particolare di corrente elettrica fa bene al cervello
Terapie presenti e future
Certo è che cambiare il modo di pensare alla depressione implica aprirsi a nuove possibilità diagnostiche e terapeutiche. Per esempio, si potrebbero studiare indici infiammatori da dosare nel sangue per porre diagnosi di depressione. O inaugurare studi su larga scala per valutare l’efficacia di una terapia antinfiammatoria, per esempio infusioni di anticorpi anticitochine (al momento i dati sull’effetto antidepressivo dei comuni farmaci antinfiammatori sono circostanziali e limitati).
Inoltre, è importante indagare il ruolo esercitato dal nervo vago, che ha notoriamente un effetto antinfiammatorio (la stimolazione elettrica del vago abbassa gli indici infiammatori) e che protegge l’organismo dallo stress e dai traumi (la teoria polivagale di Porges, per esempio, attribuisce al malfunzionamento delle fibre mielinizzate del vago i sintomi del disturbo da stress post-traumatico complesso).
Infine, acquistano sempre più forza i trattamenti che hanno dimostrati effetti antinfiammatori oltre che antidepressivi: l’esercizio fisico, il sonno regolare, i probiotici (che agiscono sul microbiota intestinale), il biofeedback, la mindfulness, lo yoga, il Tai Chi, la psicoterapia.