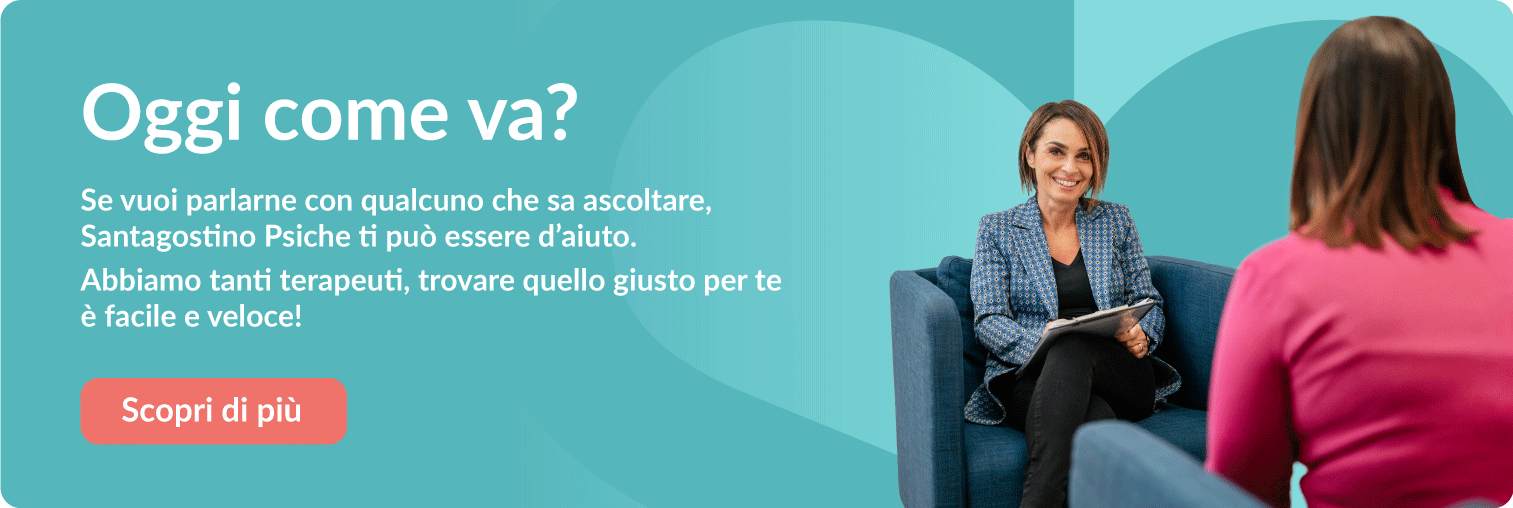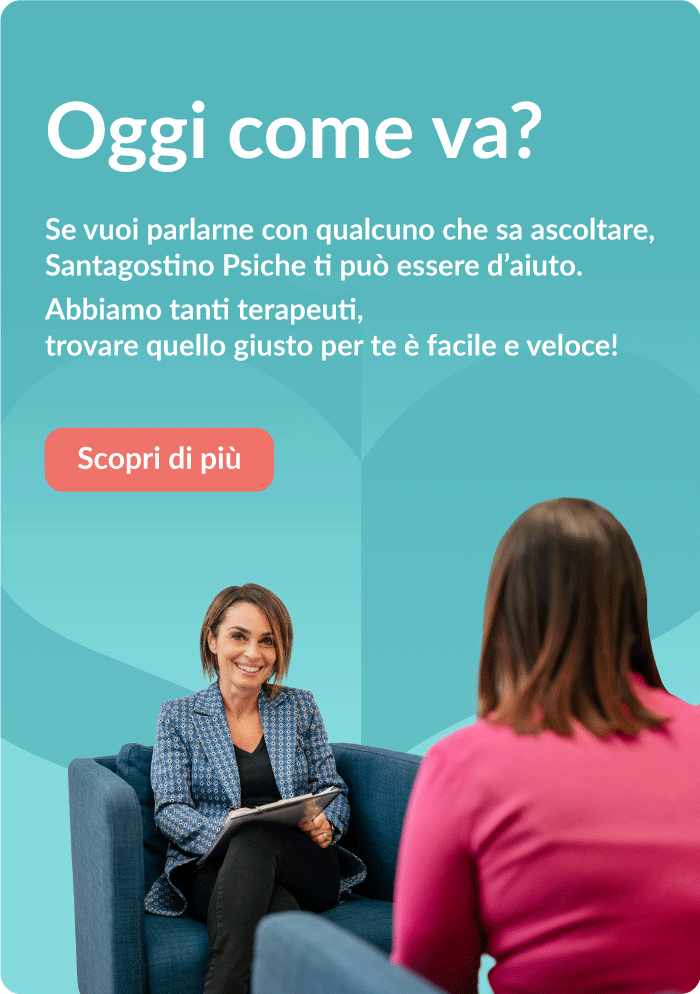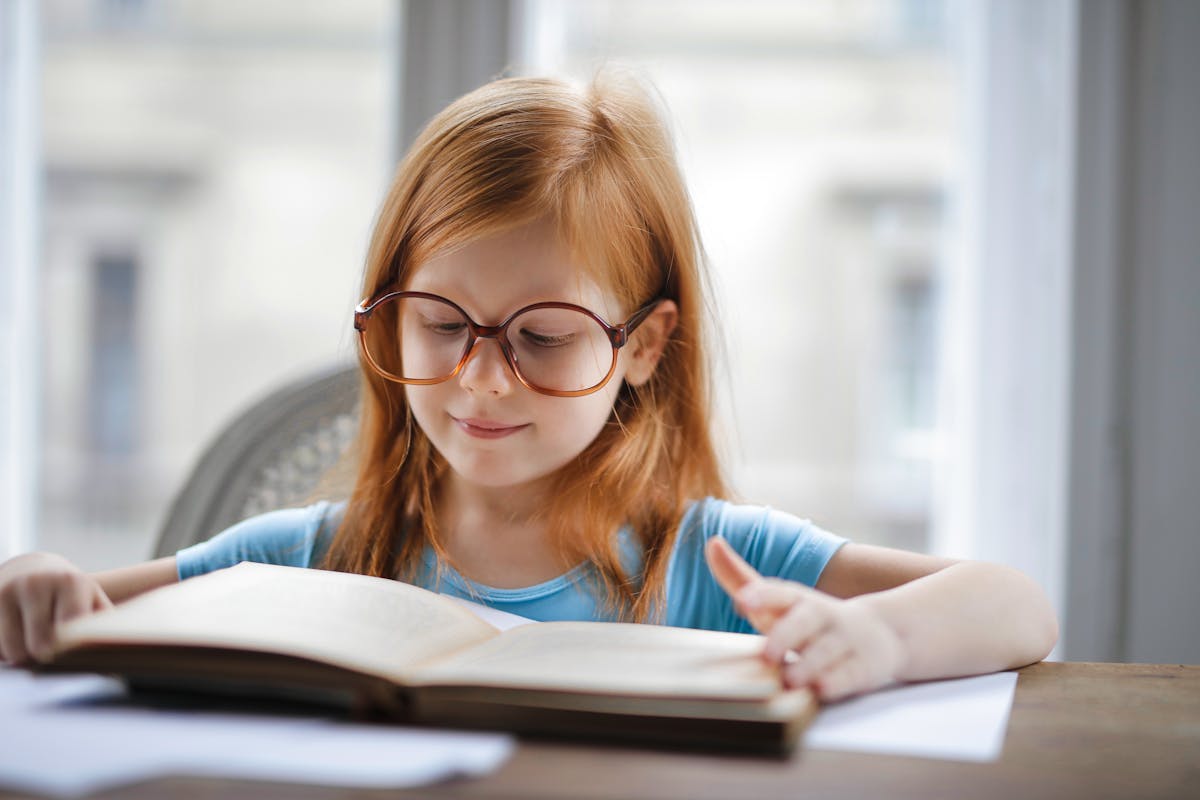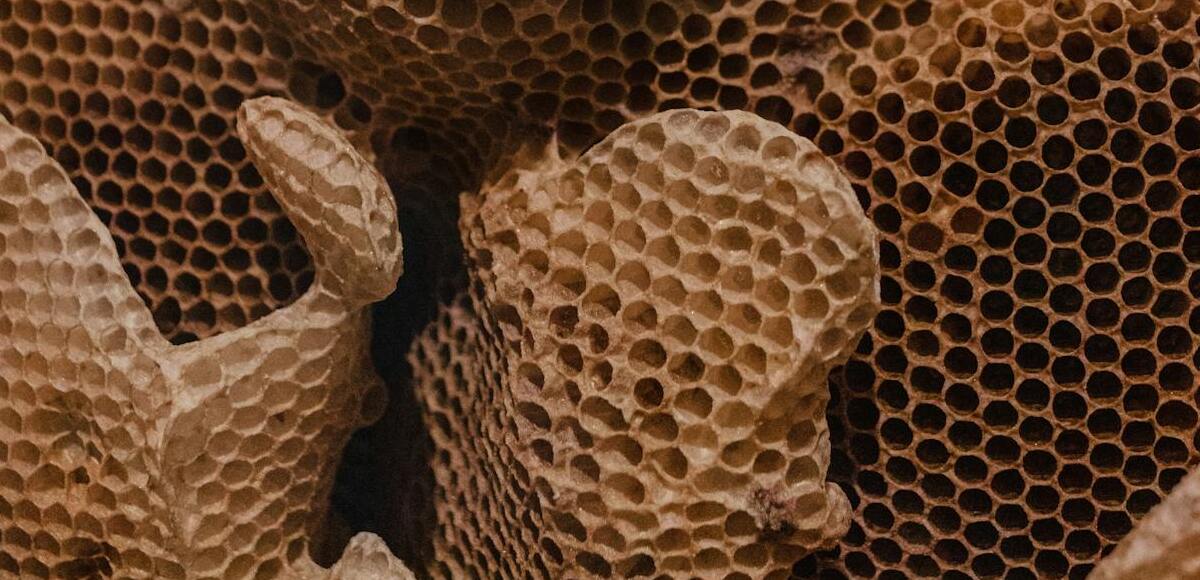In un’epoca in cui la vita virtuale è diventata quasi tanto importante che quella reale, un fenomeno sociale chiamato “sindrome da Hikikomori” sta emergendo come una sfida significativa per la salute mentale e il benessere delle persone.
Molto più che un semplice ritiro dalla società, questa sindrome è un’esperienza di isolamento estremo e auto-imposto che colpisce principalmente i giovani adulti.
L’articolo che segue esplorerà in profondità la sindrome da Hikikomori, molto diffusa in paesi ampiamente industrializzati come il Giappone, esaminando le sue cause, i sintomi, le implicazioni culturali e le strategie per affrontarla.
Scopriremo come questa forma unica di isolamento sta sfidando le nostre concezioni tradizionali di comunità, connessione e salute mentale, e perché è diventata una questione cruciale in molte società moderne. Inoltre, verranno affrontante alcune domande poste da genitori e ragazzi ai terapeuti dell’equipe adolescenti del Santagostino.
Cosa significa hikikomori?
Per capire il tema del ritiro sociale nell’adolescenza (ritiro che potrebbe essere visto come un rifiuto verso il contatto sociale) è bene partire dal significato della parola giapponese hikikomori, che alla lettera significa “stare in disparte”. Il fenomeno hikikomori nasce e si sviluppa principalmente in Giappone per poi diffondersi nelle aree del mondo più industrializzate.
Nel 2016 in Giappone sono stati registrati 514.000 casi di isolamento sociale, si trattava per la maggioranza di maschi, sia adolescenti che adulti.
Quanti sono gli hikikomori in Italia?
Gli hikikomori in Italia, si stimano in circa 100.000 casi; ragazzi tra i 14 e i 25 anni, con un possibile aumento di casi che coinvolgono anche il genere femminile.
Alcuni studi mettono in luce diverse somiglianze tra il fenomeno giapponese e quello italiano:
- fobia scolare
- qualità del legame con le figure adulte di riferimento
- l’interesse per realtà immaginarie: giochi virtuali, anime, manga e film, in cui i ragazzi si rispecchiano e investono energie emotive.
Va specificato che in Italia il fenomeno del ritiro sociale sembra assumere sfumature più ampie.
Come riconoscere un hikikomori?
Gli adolescenti ritirati sono per lo più giovani di sesso maschile e hanno un’età compresa tra i 13 e i 20 anni. La causa di questo disagio può essere ricondotta a una progressiva mancanza di fiducia in sé e a un deficit nella strutturazione della propria identità. Due condizioni, queste, da cui possono derivare sensazioni di angoscia dovute al pensiero più o meno consapevole di dovere affrontare una prestazione, con le relative aspettative da parte del mondo degli adulti e dei pari.
Il ritiro sociale può essere accompagnato anche da una forte somatizzazione, che prevede sintomi quali: dolori fisici (mal di testa, vomito) e stati d’animo invalidanti, ai limiti della condizione psichiatrica:
- ansia marcata o panico
- umore depresso
- paura dell’esterno o ansia sociale e per gli incontri.
Con l’acuirsi di questa sofferenza, possono verificarsi lunghi periodi di blocco in casa e la scuola, i centri sportivi e i gruppi di coetanei iniziano ad essere attivamente evitati.
Come passano il tempo gli hikikomori?
Il modo in cui gli hikikomori passano il tempo può variare notevolmente da persona a persona. Alcuni trascorrono il tempo navigando su Internet, da cui spesso sono altamente dipendenti, giocando a videogiochi o guardando film e serie TV. Altri potrebbero dedicarsi a hobby creativi come la scrittura, il disegno o la musica. Alcuni hikikomori potrebbero concentrarsi su attività autodistruttive o passare gran parte del tempo dormendo.
Al manifestarsi di almeno uno di questi episodi è consigliabile un primo colloquio con l’adolescente.
Quali sono le cause del ritiro sociale
Si tratta di una interazione dinamica tra più cause:
- vergogna
- senso di inadeguatezza rispetto a sé stessi e in rapporto agli altri
- senso di disagio percepito, spesso senza consapevolezza, nel passaggio dalla fase infantile a quella adolescenziale.
Quest’ultimo elemento influisce spesso sui cambiamenti dell’immagine di sé e del proprio corpo che l’adolescenza comporta. Il Santagostino, grazie alla équipe di specialisti, ha realizzato un digital book sull’adolescenza.
Quanto all’immagine di sé, è da rilevare come tra il caregiver e l’adolescente viene condiviso, in modo spesso inconsapevole, un progetto narcisistico grandioso, per il quale ogni possibile fallimento, oppure ogni eventuale delusione, rappresentano qualcosa di emotivamente intollerabile e ingestibile. Ne conseguono ansia, rabbia e frustrazione.
Anche un clima familiare depressivo, o l’avere entrambi i genitori depressi, può incidere sulla fiducia di sé dell’adolescente, proprio quando la sua fiducia è in via di costruzione.
Dalla famiglia al corpo
Anche il corpo è un fattore da considerare. Perché il corpo di un adolescente è in trasformazione, biologica e fisiologica, e la stessa psicologia risulta mutare vorticosamente. La mancata integrazione di questo sviluppo può determinare sofferenze.
L’adolescente allora, sentendosi inadeguato o non apprezzabile, tende ad adottare una strategia di camuffamento o alleviamento, fino alla eliminazione del corpo nell’interazione con gli altri. In poche parole: ha paura di essere di essere visto. Il corpo degli adolescenti comunica, anche se spesso è difficile decifrarne la lingua.
La mancanza di fiducia interna, grazie alla quale è possibile elaborare il lutto dell’ideale infantile, può svilupparsi come fonte di incertezza e portare con sé minacce di fallimento. Una protezione a tutto questo viene trovata dall’adolescente nella chiusura. Se infine, malauguratamente, a questa chiusura si associano casi di bullismo, sofferenza e senso di sfiducia facilitano l’apertura di ferite profonde.
I rischi del ritiro sociale
Il ritiro sociale viene visto dall’adolescente hikikomori come la soluzione immediata al suo dolore: somatizzazione e angosce tendono a sparire, e si ha l’illusione momentanea del controllo. Una sorta di farmaco che anestetizza le frustrazioni della vita.
In questo “bunker regressivo” i ragazzi pensano di essere al riparo dai nuovi compiti evolutivi: cambiamenti del corpo, delle responsabilità scolastiche, personali, e delle relazioni, che hanno ormai delle sfumature erotiche e sessuali. Ma il “costo” di questo farmaco errato è enorme, e può comportare:
- isolamento
- appiattimento affettivo e sentimentale
- blocchi nello sviluppo della personalità
- incapacità di confrontarsi con la realtà
- inibizione della crescita identitaria.
Come entrare in relazione con un figlio hikikomori?
I genitori faticano a capire i comportamenti del figlio ritirato. Inizialmente cercano le cause in patologie fisiche, nella svogliatezza o in atteggiamenti da “bambino capriccioso”. Questa fatica è comprensibile e dolorosa, e deriva dalla difficoltà nel vedere che la sofferenza del ragazzo è profonda, reale.
Tutte le dinamiche familiari sono messe in discussione, e il lavoro del terapeuta con i genitori consiste nel progressivo avvicinamento tra la sofferenza del figlio e quella dei genitori stessi, per sviluppare una reciproca comprensione e un mutuo ascolto. Per questa ragione, il Santagostino ha sviluppato un servizio adolescenti.
Come prevenire la sindrome di hikikomori?
La sindrome da hikikomori è un problema complesso la cui prevenzione richiede un approccio multidimensionale e multidisciplinare. Ecco alcune strategie che possono contribuire a prevenire la sindrome da hikikomori:
- Insegnare ai giovani abilità sociali a partire dalla giovane età può aiutarli a sentirsi più a loro agio nelle interazioni sociali. Le scuole e le organizzazioni possono offrire programmi di formazione sull’assertività, la comunicazione e la gestione dello stress.
- Creare un ambiente familiare empatico e sicuro in cui i giovani si sentano compresi e sostenuti. Gli adulti devono essere disposti ad ascoltare le preoccupazioni dei giovani e a cercare aiuto professionale se necessario.
- Limitare il tempo trascorso online, specialmente sui social media e nei giochi online, può aiutare a prevenire l’isolamento eccessivo.
- Promuovere l’attività fisica per contribuire a migliorare e preservare la salute mentale dei giovani.
- Integrare l’educazione sulla salute mentale nei programmi scolastici affinché i giovani sappiano come e quando chiedere aiuto.
- Essere consapevoli dei segni precoci di isolamento sociale e problemi emotivi. L’intervento precoce di insegnanti, genitori e amici può fare la differenza nella prevenzione della sindrome da hikikomori.
- Aiutare i giovani a stabilire obiettivi di vita significativi e a sviluppare un senso di scopo può contribuire a prevenire l’isolamento sociale e la mancanza di motivazione.
- Ridurre la pressione scolastica che spesso può rivelarsi opprimente. Promuovere un ambiente educativo meno competitivo può essere importante.
È importante riconoscere che la sindrome da hikikomori è complessa e che non esiste una soluzione unica. La prevenzione richiede sforzi su più fronti e un impegno continuo nella promozione del benessere mentale dei giovani.
Le risposte alle domande degli adolescenti
Di seguito un elenco di domande e riflessioni, poste da adolescenti a specialisti, e le relative risposte.
- Perché mi sento sempre così inadeguato nel contatto con gli altri? Questo senso di fragilità è conseguenza del confronto tra gli ideali propri, o della famiglia, e la realtà. Lo scarto che si produce in questo confronto determina un forte senso di inadeguatezza che ostacola la crescita. L’adolescente evita l’esplorazione di sé e non sperimenta l’erotismo, la sessualità, l’amicalità, vissuti forse nella rete.
- Il timore del giudizio mi blocca. Il tema dello sguardo dei pari è cruciale. Lo sguardo degli amici, dei compagni di classe, il confronto con i modelli estetici visti in rete possono essere vissuti con estrema sofferenza. Un commento stonato o un impercettibile risolino possono diventare fonti di umiliazioni. Comprendere il proprio modo di essere senza giudicarlo è parte centrale del lavoro terapeutico.
- Se non ho contatti con gli altri, vuol dire che sono depresso? Per una diagnosi di depressione è necessaria la presenza di alcuni sintomi: umore depresso per la maggior parte della giornata, perdita di interesse per le attività, disturbi del sonno (come insonnia o ipersonnia), idee di morte, rallentamento psicomotorio e mancanza di energia.
- Non riesco più ad andare a scuola ma vorrei studiare, come posso fare? Può verificarsi il bisogno di mettersi in contatto con la scuola e gli insegnanti, all’inizio di un approccio terapeutico, per stabilire un rientro graduale e riformulare gli impegni didattici. Si può considerare l’ipotesi di studiare da casa, supportati da insegnanti domiciliari, o sospendere la frequenza per l’anno in corso e riprendere in condizioni migliori. Il percorso è scelto col paziente, i genitori e gli insegnanti.
L’intervento clinico nei casi di adolescenti hikikomori
Nei casi di ritiro sono spesso i genitori a farsi carico della richiesta del figlio. Se però ti senti in difficoltà è importante che ne parli con qualcuno, è importante che tu riconosca il bisogno di chiedere aiuto alle persone di cui ti fidi.
Da solo o con i tuoi genitori (se sei minorenne) puoi rivolgerti a centri specializzati, anche direttamente da internet, in cui operano diverse figure professionali che accolgono la tua richiesta. Se, per esempio, inizialmente ti è difficile uscire di casa, può essere utile sapere che il terapeuta è disponibile a utilizzare telefono, pc e chat.
Ci sono educatori che possono raggiungerti a domicilio. Anche i genitori lavorano in questo percorso, collaborando con l’équipe o il terapeuta. Infine, laddove siano necessari supporti farmacologici (per esempio in presenza di quadri depressivi più consolidati), ci si può avvalere di psichiatri e neuropsichiatri.
Il Centro Medico Santagostino dà la possibilità di organizzare e prenotare un primo colloquio per adolescenti.
(3 Settembre 2023)