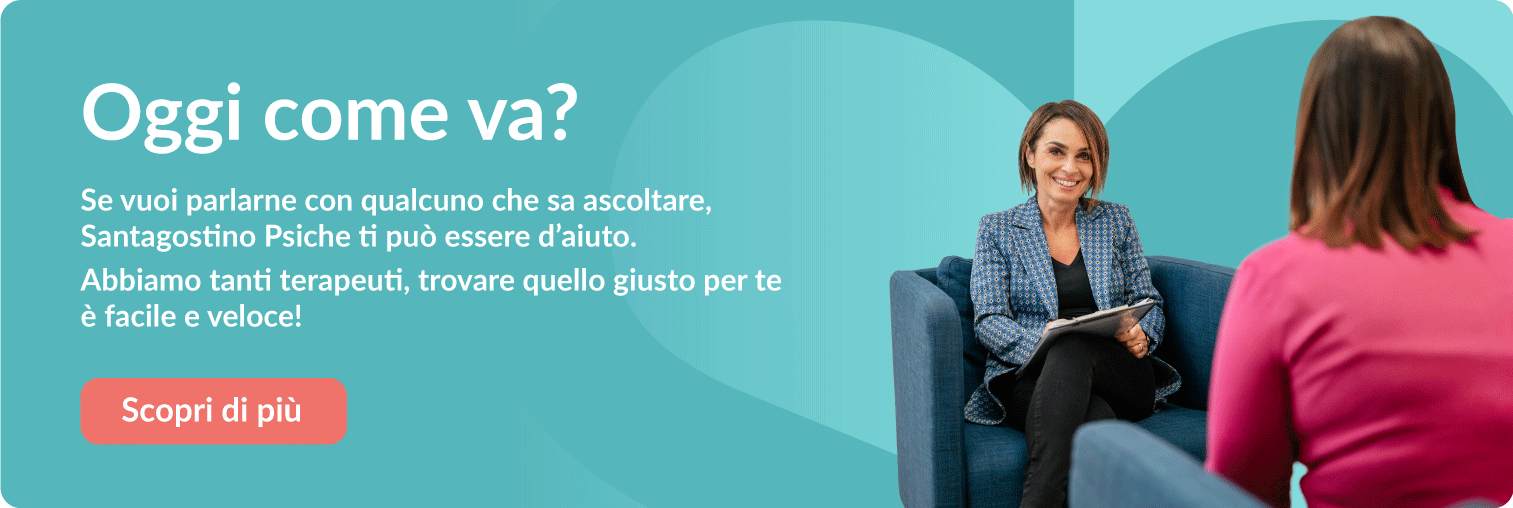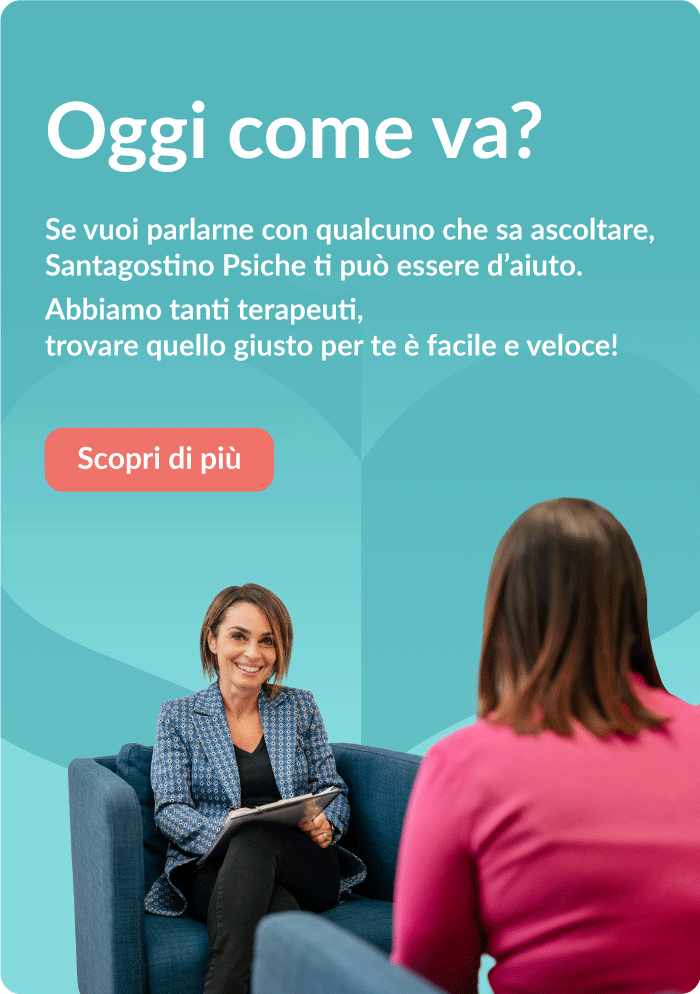Quando si parla di stalking si fa riferimento al comportamento persecutorio messo in atto nei confronti di una persona che rifiuta una relazione.
È un fenomeno diffuso: ne è vittima almeno una volta nella vita 1 persona su 5.
Si definisce “stalker” chi è ossessionato da un’altra persona, al punto da passare il suo tempo a pedinarla, telefonarle, tempestarla di mail, sms o anche a farle regali. Questo avviene nonostante l’altra non desideri le sue attenzioni o una relazione con lui/lei e abbia cercato di farglielo capire in tutti i modi. Comportamenti chiarificatori da parte della vittima sono spesso controproducenti: lo stalker non si arrende mai, nemmeno di fronte all’evidenza
Ma in che cosa consiste questo fenomeno? E come ci si difende?
Cosa si intende per stalking a una persona?
Stalking è un termine inglese mutuato dalla caccia. Significa “braccare, appostarsi per tenere d’occhio la preda”. Lo stalking comprende, infatti, un insieme di comportamenti molesti e continui, che includono:
- Appostamenti sotto casa della vittima
- Pedinamenti
- Telefonate oscene o indesiderate
- Messaggi continui
- Invio di oggetti non richiesti.
Accanto allo stalking, suscita sempre più attenzione anche il fenomeno del cyberstalking, proprio di chi molesta attraverso mail, virus informatici, diffusione di materiale personale o diffamatorio, e talvolta assumendo l’identità della propria vittima nei social network.
Ma qual è lo spartiacque tra la semplice schermaglia amorosa e le molestie vere e proprie? Fondamentalmente la posizione della vittima. Se questa ha espresso un netto rifiuto mentre l’altro non desiste, quello è uno stalker.
Quali sono le tipologie di stalker?
Nella maggior parte dei casi, lo stalker è maschio e giovane (tra i 18 e i 25 anni), anche se non mancano le donne (10-20 per cento) e non sono certo rari i casi di persone di mezza età o anziane. Alla base possono esserci motivazioni diverse. Lo psichiatra Paul Mullen (Università di Melbourne) ha tentato di darne una classificazione, distinguendo 5 tipologie di molestatore:
- il respinto
- il risentito
- il bisognoso d’affetto
- l’incompetente
- il predatore.
Il respinto
Il respinto è la tipologia più comune: rifiutato dal/dalla partner, non accetta la fine di una relazione e vuole riconciliarsi. In genere è consapevole che le insistenze, che spesso sconfinano in minacce e aggressioni, non fanno che allontanare questa possibilità, ma non riesce a farne a meno. Anche perché il senso di angoscia e di inquietudine che si accorge di provocare nella vittima rinforzano la sua volontà di rivalsa. Casi paradigmatici che ben esemplificano gli stalker di questa categoria sono la Alex di Attrazione fatale (1987) o il Noah del film Il ragazzo della porta accanto (2015). In entrambi i casi, lo stalking nasce da una fugace relazione con una persona sposata che l’amante non vorrebbe interrompere: l’escalation di azioni messe in atto a questo fine è terrificante e sempre più pericolosa.
Il rancoroso
Il rancoroso è invece alimentato da una volontà di vendetta. Ritiene di aver subito un grave torto da una persona, tanto da decidere di consacrare la propria esistenza a perseguire un piano punitivo nei suoi confronti. La molla principale è il senso di potere e di controllo sulla vittima, che gratifica e rinforza il suo comportamento. In questi casi lo stalker è spesso affetto da un disturbo di personalità, il narcisismo maligno.
Il bisognoso d’affetto
C’è poi il bisognoso d’affetto, una persona estremamente sola che cerca un rapporto intimo (d’amicizia o d’amore, il sesso è molto meno importante) con un partner idealizzato. Di questa categoria fanno parte gli affetti dalla “sindrome di de Clérambault”, descritta anche dallo scrittore Ian McEwan nel romanzo L’amore fatale. Si tratta di casi piuttosto rari, alla cui base c’è un vero e proprio delirio (è il cosiddetto “delirio erotomanico”) che comporta la perdita di contatto con la realtà: il molestatore è assolutamente convinto di essere amato da un’altra persona, in genere altolocata o famosa (spesso è un personaggio dello spettacolo).
Può bastare un niente, uno sguardo, un sorriso, un gesto, che viene mal interpretato facendo scattare le premesse di una totale intesa con l’altro. Quando l’oggetto d’amore cerca di chiarire il malinteso non ha successo perché le sue parole e azioni sono reinterpretate dal molestatore come conferma della reciprocità dell’interesse. “Mi respinge perché non riesce ad ammettere che mi ama” o “Ha paura dei suoi sentimenti” o “Teme che non lo ricambi”, e così via. Il bisognoso d’affetto dedica cioè buona parte delle sue energie mentali a reinterpretare parole e gesti della persona amata per capovolgerne il significato. Di questa categoria fanno parte gli stalker più insistenti e, per certi versi, più inquietanti.
L’incompetente
Più innocuo è l’incompetente. Il suo problema è semplicemente l’incapacità di mettere in atto i rituali del corteggiamento. Si pensi all’uomo con atteggiamenti da macho, convinto del proprio fascino e del fatto che le donne debbano subirlo. Le sue modalità sono grezze, esplicite, spesso fastidiose quando non aggressive o moleste. In genere la sua insistenza dura poco: dopo i ripetuti due di picche, l’incompetente si rivolge ad altre prede, mettendo in atto le medesime controproducenti modalità.
Il predatore
Il più raro in assoluto, nonché il più pericoloso (e il più radicato nell’immaginario collettivo), è il predatore, il vero e proprio maniaco da stereotipo. Il suo obiettivo è l’appagamento sessuale. Più che a spaventare e torturare la sua vittima (generalmente sconosciuta), si diverte a osservarla di nascosto. Sono sempre uomini e spesso vengono arrestati per molestie sessuali.
Quali sono le cause alla base dello stalking?
Le cause alla base di comportamenti di stalking possono essere complesse e variano da caso a caso, ma alcune di quelle più comuni comprendono:
- Disturbi mentali, come il disturbo borderline di personalità, il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC), il disturbo narcisistico di personalità o la psicosi. Questi disturbi possono influenzare la percezione della realtà e portare a comportamenti ossessivi
- Fissazione nei confronti della vittima, che può essere innescata da una relazione passata, sentimenti di abbandono o insicurezza, o da una percezione distorta della vittima come oggetto di desiderio
- Rottura di relazioni: la persona che fa stalking può rifiutare la fine della relazione e cercare di riconquistare l’ex partner in modo ossessivo
- Vendetta per presunti torti o ferite inflitte in passato. Questo tipo di stalking è spesso finalizzato a punire la vittima
- Esercizio di controllo: alcuni individui sviluppano comportamenti di stalking come un modo per esercitare il controllo su altre persone. Questo può essere dovuto a una mancanza di controllo nella propria vita o a una paura di perdere il potere.
- Fattori ambientali e sociali: l’abuso infantile, l’esposizione a comportamenti violenti o la vicinanza a gruppi sociali che tollerano lo stalking possono aumentare il rischio di sviluppare comportamenti persecutori
- Disagio emotivo e bassa autostima, che portano a cercare un senso di auto-affermazione attraverso il controllo degli altri
- Facilitazione tecnologica: con l’avvento della tecnologia, il cyberstalking, ovvero le persecuzioni online, è diventato più comune. La facilità di accesso ai dati personali e alle comunicazioni ha reso più semplice per alcune persone intraprendere attività di stalking.
Conseguenze sulle vittime
Le vittime del stalking si trovano ad affrontare un ampio spettro di emozioni intense e turbamenti psicologici. Queste reazioni variano dall’iniziale stato di allerta e stress psicologico a vissuti intensi e pervasivi di preoccupazione, paura per la propria vita, rabbia e disprezzo verso lo stalker, colpa e vergogna per quanto stanno subendo.
Il loro spazio privato e personale viene violato, e il senso di colpa e vergogna favorisce l’isolamento e la chiusura emotiva, riducendo la propensione a cercare aiuto e sostegno. Questo percorso conduce le vittime a sviluppare elevati livelli di ansia, disturbi del sonno e quadri psicopatologici.
Quali disturbi possono svilupparsi se si è vittime di uno stalker?
Alcuni studiosi hanno individuato tra le vittime di stalking una serie di patologie prevalenti:
- Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD): si verifica a seguito di eventi di forte impatto emotivo, come minacce di morte o atti persecutori, e comprende sogni e ricordi invasivi dell’evento traumatico, evitamento di stimoli associati al trauma e un costante disagio psicologico
- Complex Post-Traumatic Stress Disorder (C-PTSD): si sviluppa dopo esposizioni prolungate a traumi come abusi fisici, emotivi e sessuali, e comporta perdita di sicurezza, fiducia e autostima, insieme a difficoltà emozionali e interpersonali
- Somatizzazioni: problemi fisici senza cause organiche evidenti, spesso legati all’ansia e al disagio emotivo
- Avversione sessuale: a causa di episodi di stalking, compresi abusi fisici o sessuali, molte vittime sviluppano un’acuta avversione verso la sessualità, accompagnata da ansia, disgusto e una diminuzione del desiderio sessuale.
- Vaginismo: contrazione involontaria dei muscoli perineali circostanti la vagina, rendendo dolorose o impossibili le relazioni intime.
Le vittime di stalking possono anche sperimentare:
- Disturbi dell’alimentazione
- Abuso di alcool
- Insonnia
- Nausea
- Aumento del consumo di sigarette
- Reazioni depressive caratterizzate da impotenza, disperazione, paura e pensieri suicidari.
Tuttavia, è importante notare che non tutte le vittime sviluppano un disturbo psichiatrico, e i sintomi possono variare da subclinici a transitori, spesso mitigati dalla resilienza individuale di fronte a eventi traumatici.
Stalking: cosa fare e come difendersi?
A prescindere dalle tipologie – che spesso si sovrappongono, come avviene sempre quando si opera una classificazione arbitraria – il denominatore comune dello stalking è l’intrusività, e la messa in atto di molestie varie e continue.
Primo passo: non rispondere
Nella maggior parte dei casi, il molestatore ha avuto una relazione con la vittima e a essere malata è in realtà la relazione. In altre parole, quando finisce una relazione è frequente che uno dei due partner non riesca ad accettarlo, vivendo le classiche dinamiche dell’elaborazione del lutto.
Molto spesso, in casi di questo genere, la persona lasciata spende tempo ed energie a convincere il suo molestatore a smettere. Ma questo è un errore, perché è di fatto un premio ai suoi sforzi. Rispondere alle provocazioni, anche in modo negativo, consente allo stalker di mantenere viva quella relazione che egli non si sente preparato a perdere, e inoltre gli dà un senso di potere. Quindi, prima regola per le vittime di stalking: chiarire, senza ambiguità e malintesi, che non si è più interessati alla relazione, dopo di che evitare ogni contatto, e soprattutto discussioni e contro-argomentazioni. È bene anche evitare di rispondere alle lettere o di restituire regali indesiderati.
Secondo passo: avvisare parenti e polizia
Se con l’interruzione dei contatti la faccenda non si risolve e si fa anzi pesante, conviene mettere in atto misure di sicurezza. Modificare la propria routine, cambiare spesso strada durante gli spostamenti, muoversi a ore diverse e limitare l’uso dei social può essere utile per non fornire “agganci” allo stalker.
Meglio inoltre non rispondere mai al telefono e informare familiari, amici e conoscenti. Può anche essere necessario avvertire la polizia, che può diffidare lo stalker. Spesso questo basta a convincerlo a smettere. Meglio non indugiare troppo, perché le conseguenze di uno stalking assiduo possono essere anche gravi. Tralasciando i casi estremi (persecuzioni che si traducono in atti lesivi), in circa la metà dei casi la vittima finisce per sviluppare un disturbo da stress post-traumatico, manifestando sintomi ansiosi che possono durare anche per lungo tempo.
Trattamento giuridico dello stalking
In Italia, c’è voluto un po’ prima che il sistema giuridico si sensibilizzasse al problema, e non certo perché da noi lo stalking non sia diffuso (sembra anzi che una persona su cinque ne sia vittima almeno una volta nella vita). È solo dal 2009, con la “legge Maroni”, che lo stalking è considerato una condotta penalmente rilevante, configurandosi nel reato di “atti persecutori”, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Prima di questa legge, lo stalking era considerato un reato di poco conto, per il quale non erano previste misure di sicurezza. Inoltre chi denunciava spesso non veniva creduto, anche perché lo stalking è un reato cosiddetto “a fisarmonica”: si va cioè da casi molto lievi – le “normali” insistenze di chi non accetta la fine di un amore – a persecuzioni molto gravi, che mettono in pericolo l’equilibrio psicologico, e qualche volta anche la vita della vittima.
Oggi, chi subisce comportamenti persecutori può rivolgersi al questore, chiedendo un ammonimento alla persona responsabile di stalking (si tratta di una specie di diffida a non ripetere questi comportamenti). Nei casi più gravi è opportuno rivolgersi alla procura della repubblica, presentando una querela (entro sei mesi dall’ultimo atto intimidatorio o persecutorio), cui seguiranno indagini e l’eventuale incriminazione del persecutore.